Di: Silvia Chiodi
Tenutosi al Lido di Venezia il 4 dicembre 2023
L’articolo seguente è uno sviluppo di quanto esposto nel video.

Nella slide di apertura, accanto al sottotitolo “Osservazioni e temi critici” al patrimonio dissonante, ho volutamente posto un primo ed importante tema critico connesso alla distruzione di memorie non condivise: la creazione di un indice ideologico. Questo perché, come vedremo, il rischio c’è ed è molto forte e attuale.
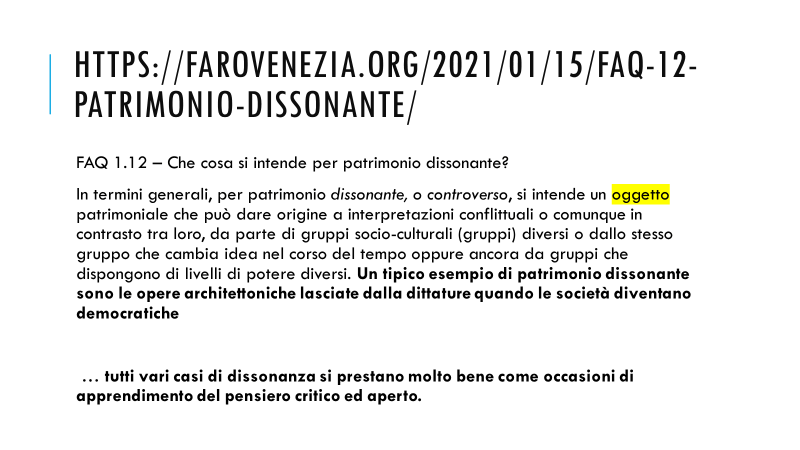
Per introdurre il problema volevo soffermarmi sulla definizione di patrimonio dissonante. Il tema però è già stato affrontato da Lauso Zagato e da Giuseppe Maino a cui rinvio.
Ricordo solo che l’oggetto patrimoniale, in quanto oggetto, è di per sé neutro, non lo è in quanto patrimonio culturale. E’ il pensiero, l’idea, che si ha di quell’oggetto, la funzione di cui lo si ammanta etc. che può renderlo controverso per la comunità e/o per le persone o gruppi di persone ad essa estranea.
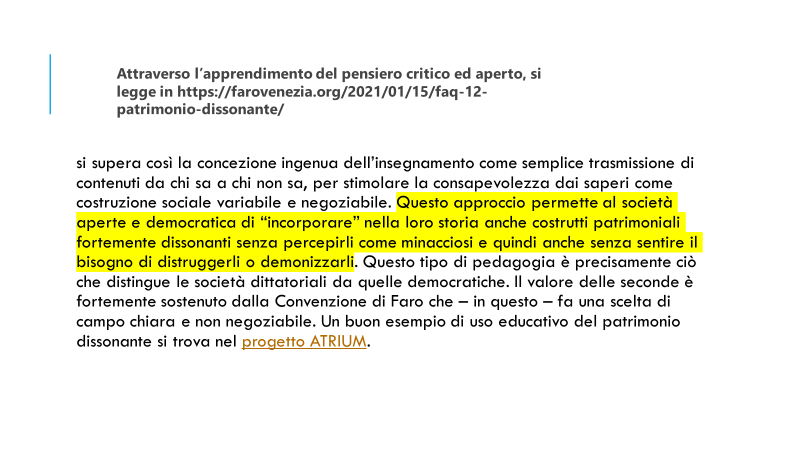
Faro Venezia ricorda, tra le altre cose, che tutti i vari casi di dissonanza si prestano molto bene ad essere occasioni di apprendimento del pensiero critico ed aperto. Attraverso la dissonanza è infatti possibile un’educazione al patrimonio per mezzo dell’adozione di un approccio critico, di dibattiti, di analisi che, in quanto tali, ci permettono, tra le altre cose, di capire perché un bene culturale viene o è stato percepito come controverso e al contempo di cercare di superare tale controversia.

Tutte le opere d’arte o meglio, tutto il patrimonio culturale – in quanto cultural – è di per sé potenzialmente controverso perché ha in sé la controversia insieme alla possibilità di non essere tale.
Poiché il patrimonio culturale in quanto portatore di valori, di simboli, di pensieri di ideologia, e di tanto altro ancora, non è neutrale le problematiche possono nascere anche da come lo presenti, come ne discuti e come ne parli.

Vorrei fare un esempio utilizzando una controversia che riguarda il discobolo Lancellotti. Reso all’Italia nel 1948, insieme ad altre opere illegalmente portate in Germania, ne è stata recentemente rivendicata la restituzione. La pretesa ha origine da una lettera in cui, da parte italiana, si richiedeva la base di marmo su cui poggiava la scultura. Richiesta a cui la Germania ha risposto richiedendo la restituzione dell’opera in quanto non trafugata ma venduta ad Hitler per volere di Mussolini (seppur vincolata dal 1909).
Ma perché ve ne parlo in questo contesto? In una mostra dal titolo Arte liberata. Capolavori salvati dalla guerra 1937-1947, allestita a Roma presso le Scuderie del Quirinale dal 16 dicembre 2022 al 10 aprile 2023, nella sezione Le esportazioni forzate e il mercato dell’arte troviamo il discobolo in questione.
Se il nostro sguardo si fermasse alla sola osservazione dell’opera d’arte contempleremmo la copia romana del celebre bronzo di Mirone e ne ammireremmo la bellezza e le forma. Ma se il nostro occhio superasse, come l’allestimento chiede, la statua, la stessa acquisirebbe di colpo un valore ed un significato profondamente diverso diventando potenzialmente controverso travalicando la prima potenziale domanda: a chi appartiene questa statua? Ponendone una seconda e più problematica: qual è il rapporto, se ve ne è, della statua con il nazismo e la sua ideologia? La risposta, a seconda del pensiero di chi la pone e risponde, cambia e può potenzialmente attribuire un carattere più o meno dissonante alla statua e provocare reazioni più o meno furiose.
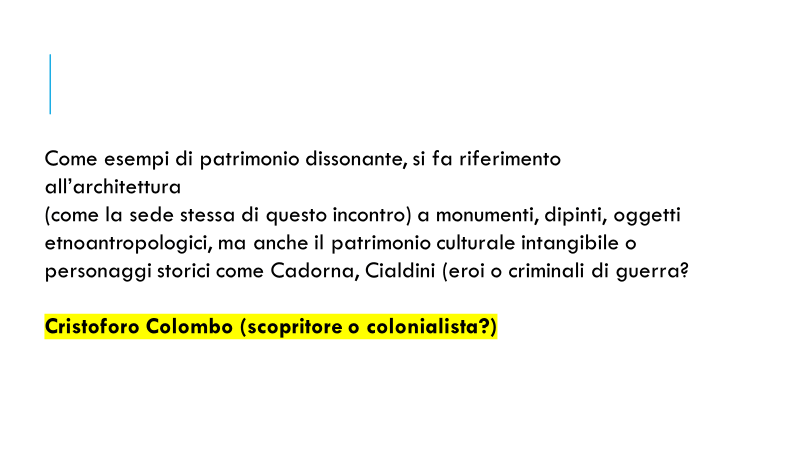
Non mi soffermo su architettura e patrimonio dissonante e se Cadorna e Cialdini siano o meno stati criminali di guerra, ma sulla figura di Cristoforo Colombo e sulla diatriba che oggi lo riguarda: scopritore o colonialista?
Mente stavo preparando la lezione per l’Università, due opere, generalmente considerati miti, ma che tali non sono, scritti in sumerico e datati alla fine del III millennio a.C. (o sarebbe più inclusivo dire a.e.v = avanti l’era volgare) hanno attirato la mia attenzione proprio in merito alle questioni di cui sopra.
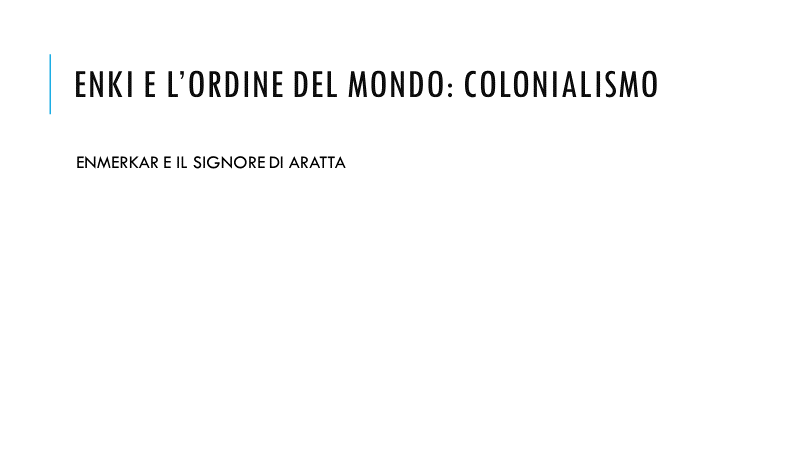
Ambedue le opere, intitolate dagli studiosi contemporanei: “Enki e il nuovo ordine del mondo” e “Enmerkar e il signore di Aratta”, non solo menzionano la presenza di colonie sumeriche che tentano, senza riuscirci, una ribellione (Aratta) o vengono “visitate” dal dio Enki durante una sua opera riformatrice “dell’ordine del mondo” e a cui il dio dispensa la sua benedizione o parole minacciose, elogiando le realizzazioni già ottenute. Colonie di cui conosciamo l’esistenza già dal periodo di Uruk (seconda metà del iv millennio a.C. ca) e nei cui testi in questione viene religiosamente giustificata l’esistenza e la funzione.
Documenti che, proprio sulla base di quest’ultima affermazione, dovrebbero essere condannati, distrutti, dimenticati.
Ma se così facessimo o se così fosse avvenuto noi avremmo perso due importanti documenti letterari ed al contempo a loro modo storici e fonti importanti per lo studio del colonialismo nell’antichità e che attestano che l’occupazione di territori oltre i confini nazionali non è caratteristica esclusiva del solo mondo occidentale, ma appartiene a molte culture e civiltà. Secondo alcuni studiosi, ad esempio, “l’espansione delle società di Uruk ha qualche somiglianza con l’espansione coloniale delle società europee nelle aree meno sviluppate del Terzo Mondo. Il fenomeno Uruk può essere caratterizzato come un primo esempio di un “impero informale” o “sistema mondiale” basato sullo scambio asimmetrico e su una divisione internazionale del lavoro organizzata gerarchicamente.”
Come tale, il fenomeno evidenzia l’importanza del dibattito e della discussione, oltre che di uno studio scientifico del tema, ed al contempo la necessità di una potenziale condanna dell’idea – in questo caso del colonialismo – che può svilupparsi in ogni cultura. In caso contrario, distruggendo ciò testimonia ciò che non ci aggrada, relegandolo alla sola cultura occidentale saremmo destinati ad una autodistruzione.

Problematiche simili le troviamo nella letteratura, nella mitologia, nei testi religiosi dove troviamo attestate idee e concezioni che oggi nessuno accetterebbe. Pensiamo, ad esempio al tema dello stupro. Un ratto famosissimo è quello di Europa per mano di Zeus. Violenza ricordata persino in una moneta europea (moneta di due euro greca) di cui però sembra che nessuno ne percepisca il valore negativo. Oltre a questo ricordiamo la pratica della schiavitù, il ruolo subalterno della donna, il problema dell’omosessualità e via dicendo.
L’importante è non distruggere ciò che la nostra sensibilità non accetta più, ma discuterne, discuterne e superare la problematica dandogli anche la giusta valenza storica e culturale. A tal uopo il bene culturale potrebbe essere utilizzato per favorire la formazione di un pensiero critico consapevoli che quel pensiero critico non è definitivo e potrebbe cambiare e svilupparsi nell’arco del tempo (e non solo in positivo).

Purtroppo non riesco a farvi vedere questo breve filmato– rimando perciò al link riportato nella slide – in cui tra le altre cose si menzionano le statue decapitate di Gudea, vissuto nel xxii secolo a.C. e che fu governatore della città di Lagash, con l’intento, secondo l’autore del filmato, di cancellarne la memoria storica.

Ora, al di là di Gudea, il senso della decapitazione, soprattutto delle statue che avevano ricevuto il cosiddetto rituale della apertura della bocca, era quello di “uccidere”, cancellandone la sua funzione. Quindi molto di più della cosidetta damnatio memoriae e della cancel cultur (se non quando applicata sulle tombe). In questi casi la statua non era considerata una semplice immagine o rappresentazione ma una duplicazione /sostituzione della persona di cui essa portava il nome. Essa era posta nel tempio, quando “il proprietario”, generalmente il sovrano, era ancora in vita con l’incarico di ricordare alla divinità cosa aveva fatto colui che rappresentava e chiedendo in cambio la vita; vita terrena e vita post-mortem. Per tale motivo, in teoria, la statua non poteva essere spostata dal luogo assegnatole anche con la morte del proprietario in quanto, attraverso la statua, il defunto continuava in qualche modo a vivere, ad essere presente in terra. Per questo l’iscrizione delle statue terminavano con delle maledizioni verso coloro che cancellavano il nome del proprietario, o la spostavano dal luogo in cui era stata posta e via dicendo. Certo non tutte le statue avevano subito il rito di apertura della bocca.

Dopodiché è chiaro che in una società multiculturale come la nostra si registra un surplus di sensibilità e di questo, per una serena convivenza, dobbiamo tenerne conto.
Il problema dei musei, soprattutto i grandi musei e non solo il British o il Louvre, sono stati per lo più impostati sulla base di una precisa filosofia della storia. L’idea infatti che sottende l’esposizione museale per lo più riflette le filosofie della storia e le ideologie del periodo.
Qual è stato il grande problema? Nasce dal fatto che se si continua ad esempio a esporre le opere d’arte secondo una visione storicistica di impianto Hegeliano o anche evoluzionista, non tenendo conto delle scoperte culturali e scientifiche avvenute nel frattempo che hanno cambiato dei presupposti teorici, significa che non solo si rischia di incorrere in un errore espositivo, ma anche offendere e calpestare la sensibilità di diverse persone e popoli. Se io ad esempio colloco l’arte sumerica vicino all’arte delle popolazioni oggi chiamate illetterate, ma allora “primitiva”, sto ponendo queste ultime, come gran parte anche del mondo africano, fuori da quella che chiamiamo storia, ma nella protostoria e / o preistoria con una precisa e parallela scala di valori culturali (i Sumeri, gli Egiziani e gli Assiri – Babilonesi ad esempio vengono collocati culturalmente prima dei Greci).
Se questo, sulle base delle conoscenze dell’800, poteva essere sostenuto, oggi le popolazioni illetterate vengono considerate contemporanee non più residui di una fantomatica preistoria e all’inizio della scala culturale.
ho fatto solo questo piccolo esempio e sono stata velocissima e forse anche troppo ma volevo proporvi delle provocazioni “riflessive”. Non solo di questi aspetti vorrei porre in evidenza non tanto il lato negativo e di protesta, ma quello positivo di crescita di consapevolezza e di rispetto. In caso contrario vi è il rischio distruttivo e di parallela creazione di un indice.
I più anziani fra noi si ricordano cos’era un indice culturale della chiesa cattolica e cosa ha significato questo per gli artisti, filosofi, musicisti, letterati, ma anche per i potenziali lettori.
Quindi attenzione al moralismo estremo. Usiamo il bene culturale per un dialogo, usiamolo il più possibile per conoscerci meglio, pensando che il mondo non è fatto di Buoni e Cattivi ma di tantissimi troppi grigi. Grazie.















